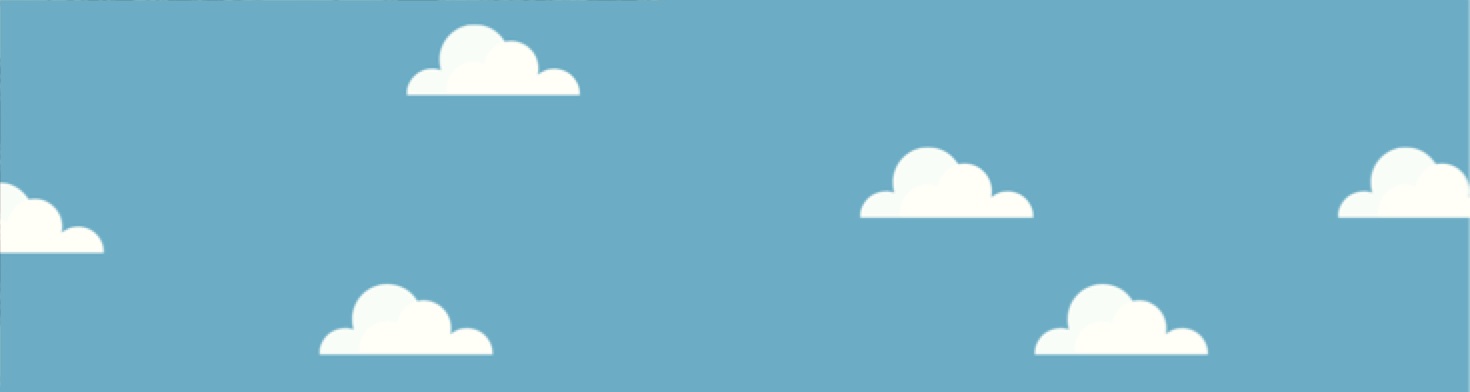Scrivere un racconto
(Rivolgendosi ai presenti) Una premessa. Non farò uso di molti avverbi. Bene o male tutti i manuali di scrittura accludono l’abolizione degli avverbi nel proprio decalogo aureo. Ma prego voi spettatori e lettori di far precedere ad ogni frase che seguirà un “tendenzialmente”, un “normalmente” o qualunque altro sinonimo più vi aggrada. Questo perché parleremo di racconti e storie brevi per cui nulla può essere detto di più vero di quanto non sia il suo stesso contrario.
E badate bene che l’avverbio che scegliete finisca in “ente”, giusto per non privarci del gusto di importunare qualche ossequioso militante dell’ordine sacro della divina, creativa scrittura.
(L’indice teso) Tu, tu e tu. Esperti narratori, pluripremiati autori e amatoriali scrittori. La domanda a voi: cos’è un racconto, cos’è una storia breve?
(Pausa) Ma che silenzio!
(Vivacemente) Ora, nel mentre che pensate, lasciatemi dire giusto due parole, non sul racconto, bensì sulla scrittura di un racconto. Qualche fisico in sala? Oh, sì, bene. Ecco una definizione che vi piacerà: la scrittura di un racconto è la manifestazione reale, scientifica e palpabile del postulato fondamentale di Lavoisier: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”.
Se la scrittura non ci costasse così tanta fatica ci convinceremmo più facilmente del fatto che ogni racconto, almeno in parte, esiste già, ancor prima che qualcuno lo immagini, lo abbozzi, lo stracci, lo riscriva, lo accartocci, lo ripristini dal cestino e lo dispieghi, lo editi e, forse, lo pubblichi. Non ne è che la riprova il timore maniacale che talvolta ci assale: il presentimento che l’idea tanto originale che abbiamo in mente possa, per un qualche cortocircuito telepatico, manifestarsi tale e quale alla mente di qualcun altro pronto ad anticiparci con una miglior copia del nostro stesso testo ancora in fieri.
Il racconto dà forma, colore e tempra a tutto ciò che ripesca dall’indistinto e miscellaneo pot-pourri di eventualità che ogni giorno il caso sparge sulla nostra strada. Così, la scrittura di un racconto diventa un viaggio in treno lato finestrino con, al contempo, vista favorevole sulle vicende dell’intero vagone che potremo scegliere di ignorare o origliare. Il racconto parla di ciò che rimane dopo una selezione di ordinari miracoli ed eccezionali normalità che spaziano, s’arrampicano e corrono a raggiungere l’altro e, ancora più spesso, l’altro ancora in un commisto processo di immedesimazione e sfacciata indiscrezione.
(Ammiccando con tono confidenziale) Perché diciamocelo chiaramente: quello del racconto è un feticismo come altri, fatto di sguardi smaliziati e pregiudizi impazienti di smentite. Pone le sue perverse radici nello stesso piacere criminoso che ci assale quando leggiamo una nota della spesa incollata al pavimento umido del supermercato, quando, in attesa di attraversare la strada, scorriamo gli annunci affissi al semaforo, quando, distrutti dalla scarpinata, ci mettiamo a sfogliare le dediche e le speranze affidate dagli escursionisti al libro di vetta nella cassetta ghiacciata ai piedi della croce.
Sono parole spesso anonime, estranee e accidentali. Eppure ci sembrano parlare del mondo con brillantezza e fiuto, tanto da darci l’infantile percezione di tradire un segreto noto solo a qualche massone dell’ultima schiera. E tanto più queste parole sono lontane da noi, dal nostro gergo, dalle ordinarie costruzioni verbali, tanto più vivo è il senso di verità che gli attribuiamo. Così le parole pescate dagli altri dal pallottoliere delle possibilità suonano quasi sempre migliori, meritevoli di invidia mascherata da ammirazione. Come quando, per puro caso, ci ricapitano fra le mani vecchie righe scritte da noi. Abbandonate a invecchiare, fermentare e stagionare nella cantina dell’oblio, le scopriamo tramutate da testo da censura a ispirato brano pubblicabile.
(Alzando la mano) “Detesto scrivere. Ma amo aver scritto.” È forse la frase più ricorrente nelle confidenze biografiche di molti scrittori.
Ve ne darò un’altra dimostrazione. Suspension of disbelief: on.
(Con voce fioca) Siete su di una spiaggia, fa caldo e vi siete appena sgolati una bottiglia di succo d’ananas. Ora: preferireste scrivere un messaggio, arrotolarlo, infilarlo nella bottiglia appena vuotata e abbandonarlo al mare perché, a distanza di decenni, venga ritrovato da qualche avventuriero o, passeggiando lungo la riva, preferireste scoprire voi un’antica bottiglia galleggiare con al suo interno un enigmatico messaggio?
Al di là della ragione ambientalista, sono piuttosto sicuro che la maggior parte preferirebbe trovare un messaggio piuttosto che scriverne e abbandonarne uno proprio.
Ideare e costruire un racconto è un atto faticoso e, in un certo qual senso, altruista. Ci siamo lasciati indottrinare dal senso pratico per cui ogni nostro pensiero e ogni nostra azione debbano rispondere ai principi della razionalità e dell’efficienza. Ma non è sempre stato così. Il momento di distacco è da far risalire a quando, per la prima volta, tra i dieci e i quindici anni, giocando a nascondino, abbiamo smesso di contare a voce alta; il volto nelle pieghe di un angolo del cortile, per la prima volta mettemmo in discussione il senso di contare a voce alta da soli, poi l’utilità di contare, infine il senso stesso di giocare: “98, 99, 100. Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro.”
La scrittura di un racconto è un ritorno a quell’istinto fanciullesco per ciò che è momentaneo, fuggevole e inefficiente. È uno stile di vita, una forma mentis, un approccio distaccato dai grandi accadimenti che, pur non ignorandoli, li approccia movendosi dal basso, dal piccolo, facendosene fagocitare a poco a poco. Come dice Aldo Busi in “Cazzi e canguri”: “Mi sento in questa vita come quando mi lavo, mi vesto e vado in discoteca per divertirmi, dopo tre minuti non faccio più parte dei clienti, ma del personale.”
(Dopo aver riflettuto a lungo) Ora, nel racconto, questa improduttività del contenuto viene sobbarcata da un’estrema efficienza del linguaggio: una concentrazione vivida del significante come il gusto di certi confetti alla rosa che, se avete la fortuna di capitare fra i carruggi di Genova, potete provare: una goccia di rosolio liquido racchiusa in un sottilissimo involucro di zucchero. (Umettandosi le labbra) Una bomba a orologeria sulla lingua! E questa concentrazione richiede una mente creativa, attenta, che sappia spaziare e creare “le analogie più lontane, avvicinando le parole e le pietre”, dice Pietro Citati, per “ricostruire il perfetto equivalente di ciò che un tempo era accaduto.”
Con cognizione o inconsciamente, questo è quello che facciamo. Ma cosa deve dire oggi un racconto? Quello che poteva dire nel Seicento o nel Novecento, in Europa o in Oceania.
E perché scriviamo racconti? (Alzando le spalle, con una smorfia) Perché ci hanno detto che è l’unico modo per pubblicare, perché ce l’ha consigliato il terapeuta, per rivendicare una capacità che non vogliamo lasciare allo sfruttamento esclusivo di qualche agenzia pubblicitaria, perché ci sono storie che vogliamo raccontare, perché, perché, …
(Più forte) Abbandonate i perché e siate pronti a cogliere il vostro prossimo messaggio da imbottigliare, ma siate attenti, potrebbe passare in ogni momento.
(Beve un bicchiere d’acqua. Si rivolge alla sala) Qualcuno nel frattempo ha pensato e vuole dirci cos’è per lui un racconto?
–
a cura di Mario Barbarino — la Rivisteria